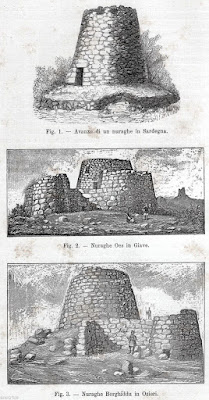di Marcello Cabriolu
Ph Internet
Il
monumento venne scoperto nel 1953 dai Sig.ri Sanna, proprietari del terreno che
in origine si chiamava “Sa Costa de sa Binza”, mentre cercavano di terrazzare
il fianco del monte per impiantare un frutteto. Il nome “Su Tempiesu” è legato
a un mito della zona in cui si parlava di un uomo proveniente da Tempio che,
nei primi del ’900, lavorò al taglio dei boschi per produrre carbone. La prima
campagna di scavi avvenne nel 1953 ma i resoconti relativi vennero pubblicati
solo nel 1958. La necessità di un restauro, vista la progressiva rovina del
monumento, richiese un intervento della Soprintendenza Archeologica che durò
dal 1981 al 1986 e fu gestito dalla Prof.ssa Maria Ausilia Fadda, attraverso il
quale venne intrapresa un’indagine più approfondita. Si scoprì allora che le
genti preistoriche avevano individuato la presenza della falda d’acqua che
scaturiva dalla roccia scistosa, e vi avevano eretto la costruzione a pianta
rettangolare.

Utilizzando della trachite e lavorandola a martellina, gli
Shardana crearono, addossata alla roccia, una struttura templare con tetto a
doppio spiovente che rispetta il principio edilizio dei nuraghi: il muro a
sacco. La rifinitura dei pezzi del tetto venne curata in maniera esagerata,
risparmiando solamente quelle che ora vengono definite “bugne” ma che in
origine dovevano essere lunghe corna riprodotte in onore della Dea Madre, come
si fece nel Pozzo Sacro di Perfugas. Il prospetto venne rifinito con una sorta
di cornicetta, il timpano, di forma triangolare, che presentava degli incavi in
cui vennero trovate infilzate delle spade di bronzo, dal basso verso l’alto,
fissate con colate di piombo. Sotto il timpano venne lasciato uno spazio vuoto,
di luce triangolare, dove vennero posti due archi in pietra a soprastare il
vestibolo del pozzo. Il piano di calpestio venne completamente lastricato
lasciando lo spazio per una canaletta d’acqua e il deflusso del pozzo. Ai lati
del vestibolo vennero ricavati i sedili e il pozzetto venne incorniciato con un
portello e una soglia con beccuccio adduttore corrispondente alla canaletta di
scolo. L’imboccatura del pozzetto venne strombata verso l’esterno e dotata di
gradini simbolici verso il pozzetto di captazione e la parte superiore
architravata con gradoni rovesci.
Al momento della scoperta e del restauro si
notò che tutti i conci e i blocchi erano saldati tra loro da verghe di piombo,
addirittura nel pozzetto i lati erano stati rivestiti di piombo per evitare la
fuoriuscita dell’acqua. Alcuni studi sostengono che il tempio fosse in origine
circondato da un recinto, ma osservando la struttura viene spontaneo ritenere
che anticamente esso fosse cupolato a tholos e solo dopo fosse stato
ristrutturato a doppio spiovente. L’area antistante il vestibolo rivelò un
recinto curvilineo che alla base, nel punto in cui scolava la canaletta,
terminava in un bacile in pietra con beccuccio per un ulteriore scolo. Affianco
è presente un concio, inserito nel muro della struttura, che riporta un viso
scolpito con le sembianze della divinità, ovvero l’arcata sopraccigliare e il
setto nasale ben marcato. Il bacile fu oggetto di deposito di numerosissimi
oggetti in bronzo quali spade, bottoni, bracciali, stiletti, anelli e bronzetti
mentre l’esplorazione stratigrafica dei vani del complesso ha riportato alla
luce due ambienti ben definiti usati da deposito per gli ex-voto rimossi dal
pozzetto.

Come arrivare
Lasciare l'abitato di Orune e seguire le
indicazioni per Su Tempiesu. Giunti in prossimità del cimitero, svoltare
in una stradina asfaltata che conduce, dopo pochi chilometri,
all'ingresso dell'area archeologica. Si lascia l'auto e si procede a
piedi per un sentiero in discesa che, dopo alcune centinaia di metri,
termina davanti alla fonte.
Bibliografia
G. Lilliu, "Nuovi templi a pozzo della Sardegna nuragica", in Studi Sardi, XIV-XV, 1955-57, p. 244 ss.;
M.A. Fadda, "Il Tempio a Pozzo di Su Tempiesu (Orune, Nuoro)", in Rivista di Scienze Preistoriche, XXXVII, 1982, p. 284 ss.;
M.A. Fadda, "Il Tempio a Pozzo di Su Tempiesu (Orune, Nuoro)", in La Civiltà nuragica, Milano, Electa, 1985, p. 208;
V. Santoni, "I templi di età nuragica", in La Civiltà nuragica, Milano, Electa, 1985, p. 181 ss.;
M.A. Fadda, "Su Tempiesu di Orune e il culto nuragico delle acque", in Archeologia Viva, XVIII, 74, 1999, pp. 78-83.